
Da “Un altro Ferragosto” ad un’altra Italia, recensione di Carmelo Sciascia
Credo di avere visto tutti i film di Paolo Virzì, di alcuni ricordo la trama, di altri i personaggi e…
Claudio Arzani (arzy) scendincampo e racconta e scrive, e scrive poesie, e scrive racconti, e scrive di sogni, sempre e ancora sogni d'Utopia




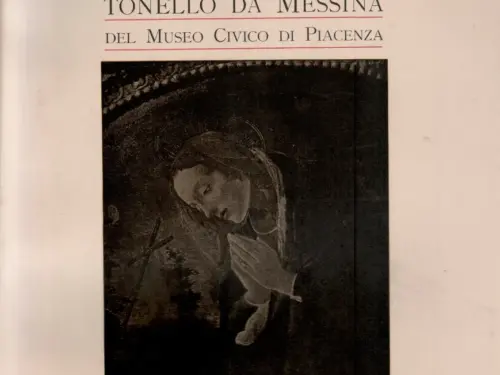

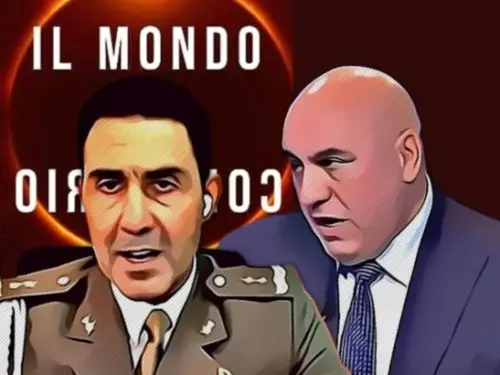

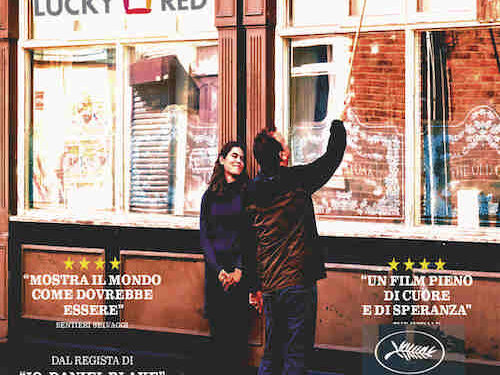



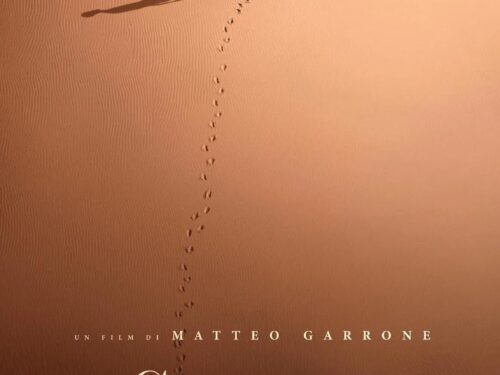


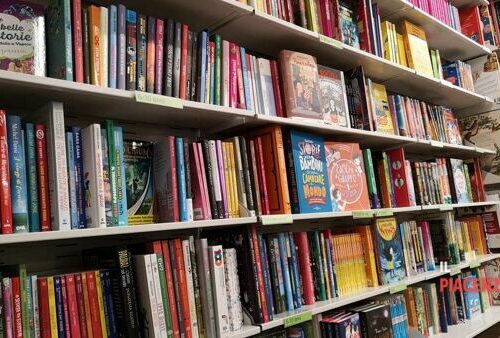
Tema Seamless Keith, sviluppato da Altervista
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario