
Sabbioneta: nella Sinagoga dove i maschi per obbligo coprono il capo con la Kippah ma le donne, no!
Un’interessante esperienza personale: la visita alla sinagoga di Sabbioneta, luogo di culto ebreo. I primi ebrei arrivarono a Sabbioneta nel…
Claudio Arzani (arzy) scendincampo e racconta e scrive, e scrive poesie, e scrive racconti, e scrive di sogni, sempre e ancora sogni d'Utopia

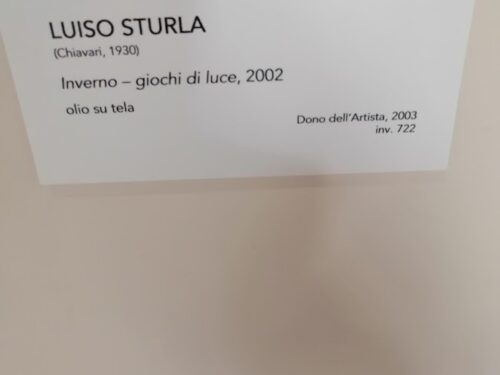




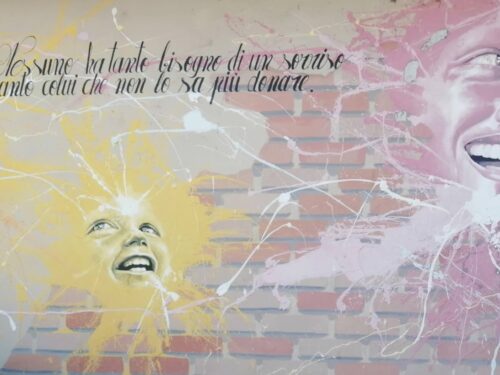








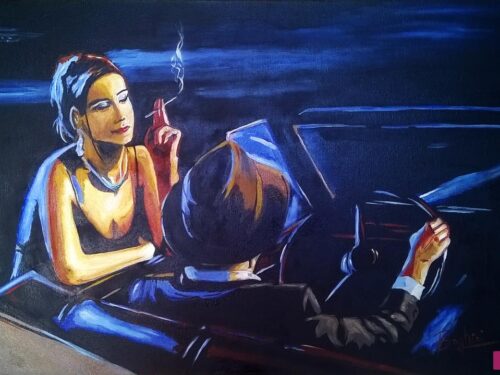
Tema Seamless Keith, sviluppato da Altervista
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario